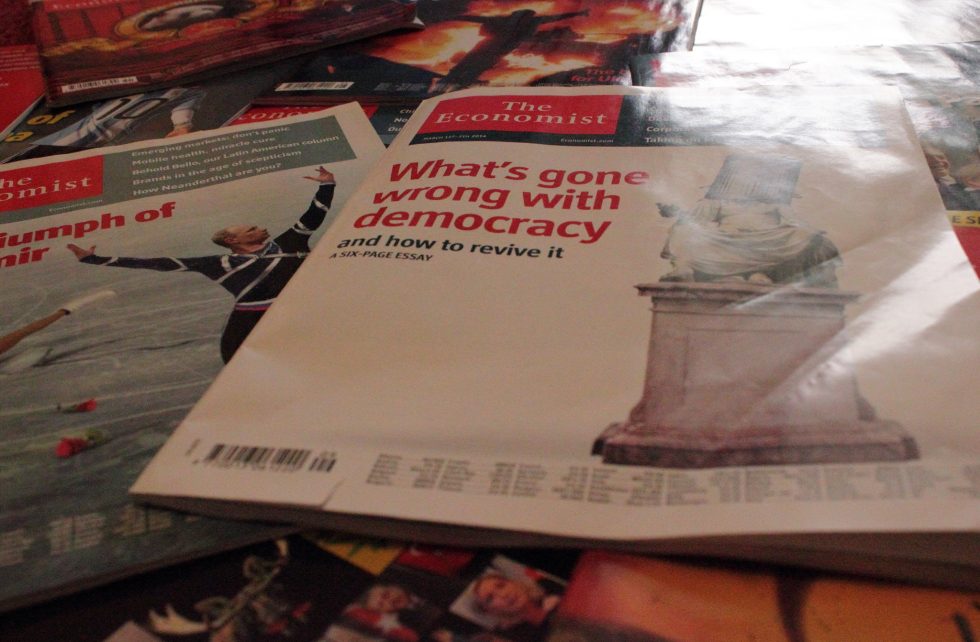
Foto copertina: Rukhshona Nazhmidinova, European Journalism Observatory, Flickr.
L’Economist ha avuto da sempre una posizione atipica con le società di intelligenza artificiale e i loro strumenti. Non ha mai stretto accordi di licenza con OpenAI e simili, né ha mai intentato rumorose cause legali contro di loro.
I vertici del settimanale britannico si muovono con accortezza lungo un filo molto delicato, quello che lega l’industria dei media e le big tech che impiegano i propri chatbot come mezzo di informazione.
Da un lato c’è la consapevolezza, espressa dal presidente dell’Economist Luke Bradley-Jones a Press Gazette, che gli strumenti basati sui modelli linguistici di grandi dimensioni – Llm – sono “esperienze di prodotto progettate come destinazioni finali”, che “non mirano a indirizzare traffico verso editori terzi”.
Inutile e dannoso, dunque, cercare di puntare su ChatGpt per risollevare il calo delle visite sul sito del giornale, se ChatGpt e gli altri chatbot sono essi stessi “piattaforme editoriali”, che non hanno “alcuna intenzione di generare link o traffico verso terze parti”.
Per questa ragione, l’Economist Group non ha stretto collaborazioni con aziende di IA per l’utilizzo dei propri contenuti editoriali.
Dall’altro, Bradley-Jones ha spiegato come il magazine si basi tuttora su un modello nel quale il traffico organico da motori di ricerca non rappresenta “una parte importante”, nonostante abbia “avuto un ruolo significativo”.
Questo ha fatto sì che la diminuzione degli accessi ai siti delle testate, causata dall’introduzione dei servizi IA di Google, in particolare AI Overviews e AI Mode, abbia toccato la rivista londinese in maniera soltanto marginale.

Foto: Wikimedia Commons.
Quali alternative
Il presidente dell’Economist, intervistato dal direttore di Press Gazette, Dominic Ponsford, ha delineato l’approccio del periodico nei confronti degli strumenti esterni di IA.
Innanzitutto, ha sottolineato come, per un’azienda da 368,5 milioni di sterline di fatturato e un margine operativo di 48,1 milioni, andare in causa contro colossi della tecnologia sia un’operazione rischiosa per gli alti costi legali che comporterebbe.
Il magazine, ha detto Bradley-Jones, è “relativamente piccolo” e dovrebbe “impegnare risorse molto significative per intraprendere quella strada”.
La strategia da seguire, secondo il presidente della rivista, è quella di un mondo definito post-Google e post-search, e riassumibile in tre punti principali: differenziazione delle fonti di ricavo, relazioni dirette con i vari tipi di pubblico e clienti e capacità di essere visibili e riconoscibili.
Ancora una volta, il presupposto fondante per mettere in atto questo piano è la qualità del prodotto, che deve mantenere i tratti tipici del lavoro umano per essere unico, personalizzato e multi-canale, sfruttando soprattutto i contenuti audio e video.
Nell’epoca della frammentazione dei media, l’originalità dei prodotti passa anche dalle piattaforme utilizzate per diffonderli.
Non a caso, l’Economist è stata la prima testata, insieme all’Atlantic, a sbarcare su NotebookLM, uno strumento IA di Google che permette di analizzare dei documenti caricati dall’utente e rispondere a domande in merito, generare riassunti e creare diversi contenuti interattivi, basati soltanto sulle fonti selezionate.
In particolare, il notebook dell’Economist è basato sul suo rapporto annuale The World Ahead, che si compone di analisi di politica internazionale ed economia.
Il settimanale ha anche aperto il proprio account su Substack, dove pubblica la sua newsletter di data journalism Off the Charts e ha circa 2.300 follower.
Ci sono poi i ricavi da 1,25 milioni di abbonamenti all’Economist, con tariffe che si aggirano sulle 230 sterline all’anno.
Secondo Bradley-Jones, i due tipi di consumatori, quelli di Substack e gli abbonati, non dovrebbero sovrapporsi, poiché su Substack “pensiamo ci sia un pubblico da raggiungere, ma non andrà a cannibalizzare quello che offriamo con il nostro abbonamento principale”, che è sì interessato al data journalism di Off the Charts, ma usufruisce anche degli altri contenuti del magazine.

L’evento India Summit, organizzato dall’Economist a Mumbai nel 2019. Foto: Wikimedia Commons.
Spazio agli eventi
Mentre alcune aziende di IA, come Perplexity, stanno provando a diffondere un nuovo modello di collaborazione con i giornali e non basato esclusivamente sui contratti di licenza, l’Economist sta innanzitutto puntando sulle capacità e sul proprio blasone, in tre modi.
In primo luogo, attraverso gli eventi organizzati dalla testata, un suo marchio di fabbrica.
Come ricorda Press Gazette, la rivista ne organizza circa 130 ogni anno e, sottolinea il suo presidente, si tratta di un settore “cresciuto molto bene negli ultimi anni”.
La gran parte di questi sono organizzati e curati dal dipartimento Economist Impact, che ha generato lo scorso anno 97,7 milioni di sterline di ricavi e conta su oltre 500 clienti, 600 sponsor e, nel 2024, oltre 22mila partecipanti.
Un’altra area remunerativa per il giornale è Economist Intelligence Unit, la divisione del gruppo specializzata in ricerca e analisi. Fornisce report periodici di vario tipo e, tramite strumenti finanziari, offre previsioni economiche ai clienti – da aziende a governi e organizzazioni non-profit.
L’area Economist Intelligence ha portato al gruppo 44,2 milioni di sterline di fatturato.
Resta infine il più classico dei canali di remunerazione dei media: la pubblicità.
Bradley-Jones ha dichiarato che il valore economico delle inserzioni sta crescendo per la testata e si tratta di un business in crescita su cui l’azienda si sta concentrando di più rispetto agli ultimi cinque anni, durante i quali “non ha rappresentato un grande focus strategico”.
Sommando le varie componenti, un mix di canali tradizionali e innovativi, nell’ultimo anno l’Economist è riuscito a ottenere il miglior risultato economico della sua storia.








