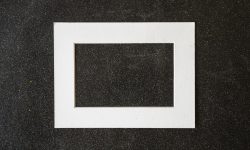Sembra strano scrivere di quotidiani in un momento di esplosione digitale, moltiplicazione di fonti di informazione e piattaforme, disintermediazione dei giornalisti tradizionali e di lettori in grado di trasformarsi in produttori di informazione – o almeno in commentatori seriali.
Eppure, se si guarda al mercato dell’informazione giornalistica – escludendo l’intrattenimento e le informazioni di servizio – i quotidiani mantengono una loro importanza, nonostante il rovinoso calo di copie e di lettori che hanno sperimentato negli ultimi dieci anni.

Foto: Canva.
Perché vale un quotidiano
Quando un ufficio stampa fa un piano di comunicazione, i dirigenti dell’azienda guardano certo le uscite sui siti e le newsletter, ma sono molto attenti alla possibilità di un articolo su un tradizionale quotidiano cartaceo.
Le sue pagine offrono ogni giorno un panorama informativo di un centinaio di notizie, più delle venti che di solito compongono un telegiornale.
Motivo per cui, oggi, il giornale cartaceo è importante non tanto per le notizie che contiene ma per quelle che esclude. Le notizie che contiene sono infatti considerate rilevanti proprio perché c’è stato un processo di selezione.
Da questo punto di vista, i mezzi digitali, che spesso lavorano senza un limite rigido di magazzino, esercitano in modo meno stringente il processo di gatekeeping.
Per un paio di secoli, i quotidiani hanno svolto questo servizio di selezione e gerarchizzazione delle informazioni per le classi dirigenti.
Un servizio prezioso di agenda setting che ora, con il rimpicciolirsi progressivo delle redazioni, rischia di andare disperso.
Infatti, nel mondo digitale non è emersa nessuna piattaforma che svolga questo servizio.
C’è una moltiplicazione di informazioni, ma non è facile individuare quelle rilevanti, poiché non sono associate a un livello di credibilità e qualità più o meno conoscibile a priori.

La sede del Corriere della Sera, in via Solferino a Milano. Foto: Wikimedia Commons.
Lunga vita al locale
Nonostante il loro ruolo strategico, il settore dei quotidiani ha sperimentato una crisi devastante negli ultimi dieci anni.
Le copie cartacee – che comprendono quelle vendute edicola e gli abbonamenti – sono scese del 60%.
Il calo è stato più pronunciato per i quotidiani nazionali rispetto a quelli locali che, grazie alla dominanza nella loro provincia e alla forza nel presidiare le informazioni nella propria area di pertinenza, hanno leggermente limitato il calo di copie.
Questo calo è stato in parte controbilanciato da una crescita delle copie digitali, ma anche considerando queste ultime – solo quelle degli abbonamenti digitali venduti ad almeno il 30% del prezzo pieno – la riduzione complessiva è stata comunque nell’ordine del 55%.

Dietro la crisi
Il meccanismo di crisi non dipende dall’incapacità dei direttori.
Il quotidiano è un bundle – un fascio – di notizie vendute assieme.
Ma quasi nessun lettore legge tutto il giornale, ognuno lo compra per il suo sottoinsieme preferito.
Se qualche informazione, anche secondaria, diventa disponibile gratuitamente, qualche lettore trova che il giornale non valga più il prezzo di copertina.
Col tempo la testata deve ridurre i costi fissi, cioè le redazioni, per non fallire. Ma i costi fissi sono responsabili della sua qualità che, scendendo, spinge qualche altro lettore a smettere di acquistarlo – in un circolo vizioso di decadenza dove il calo di qualità è conseguenza e non causa.

Foto: Canva.
Le rese e il loro significato
Un altro effetto del calo delle copie è stata l’esplosione delle rese, ossia quelle copie non vendute che vengono restituite all’editore.
Al contrario di quello che molti credono, non sono uno spreco – o almeno non tutte lo sono.
Il quotidiano è distribuito in conto vendita, ossia il rischio commerciale è assunto dall’editore e non dall’edicolante.
È un meccanismo razionale, sia perché l’edicolante è più avverso al rischio, sia perché egli fronteggia un rischio superiore a quello dell’editore.
Se un cliente decide di comprare il quotidiano altrove, questa perde una vendita, mentre per l’editore non cambia nulla.

Foto: Flickr.
Per le edicole, l’obiettivo logistico ideale è avere una copia di reso per punto vendita.
Il tasso di reso – cioè la relazione percentuale tra le copie rese e le copie tirate – è dunque un indicatore di efficienza distributiva.
Naturalmente sia dal denominatore – la tiratura –, sia dal numeratore, bisogna sottrarre le copie che non c’entrano con le vendite in edicola, cioè gli abbonamenti e gli omaggi, le vendite in blocco – consegnate a compagnie aeree e aziende ferroviarie –, dove le quantità sono stabilite a priori e quindi non generano nessuna resa.
Ad esempio, Avvenire ha una tiratura di circa 95mila copie, ma, di queste, oltre 70mila sono distribuite tramite abbonamenti e vendite multiple – a parrocchie ed enti ecclesiastici.
In edicola, le copie vendute sono 4.800.
Il tasso di reso dipende naturalmente dalle quantità distribuite, dalla concentrazione geografica delle copie e dalla numerosità dei punti vendita serviti.
Prima del calo, i migliori livelli di resa – tra il 20 e il 23% – erano raggiunti dai quotidiani provinciali forti e dai quotidiani nazionali con oltre 200mila copie vendute in edicola.
I quotidiani nazionali di opinione, più piccoli e senza una diffusione capillare sui territori, avevano e hanno facilmente tassi di resa superiori all’80%.

Rimedio digitale (per pochi)
Alla crisi della distribuzione cartacea sembra facile rispondere con gli abbonamenti digitali.
Tuttavia, i lettori cartacei rendono meno di quelli digitali e, in più, gli abbonamenti alla versione digitale sono concentrati in poche testate.
Le prime cinque concentrano infatti circa i due terzi degli abbonamenti digitali complessivi.
Insomma, la vita per i quotidiani sta diventando difficile, ma non è detta ancora l’ultima parola.
Costituiscono un ingrediente prezioso del panorama informativo e, sebbene ci sarà probabilmente una riduzione del loro numero, quelli capaci di reinventare sia il modello di business sia il modo di fare informazione potrebbero sopravvivere.