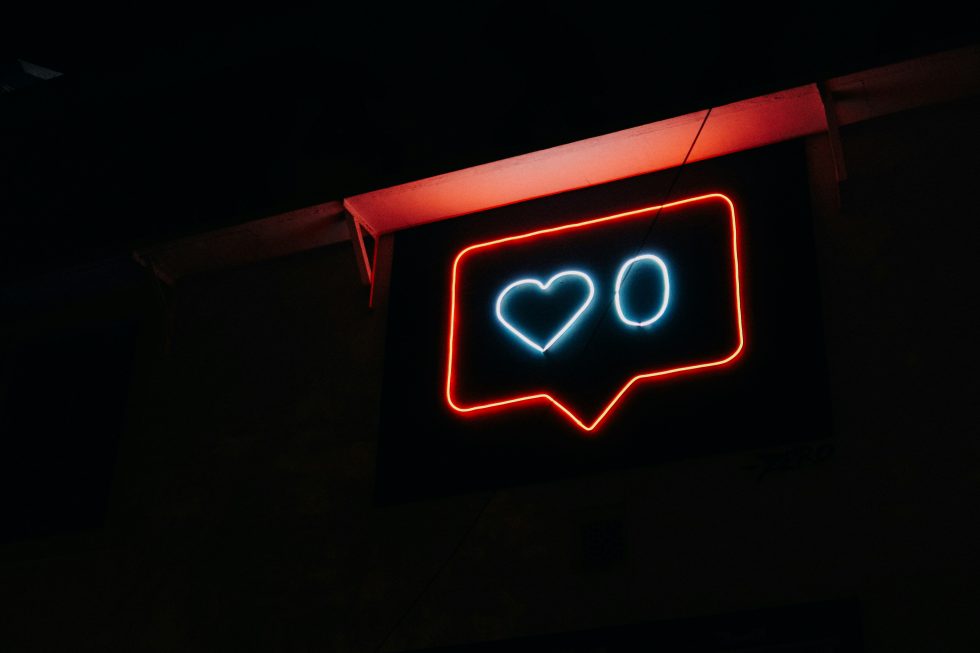
Foto copertina: Unsplash.
Nel mercato digitale dell’attenzione, i social media sono diventati un acceleratore di polarizzazione, radicalizzazione e impoverimento del dibattito pubblico, con costi economici e sociali ancora sottovalutati.
Le piattaforme come Facebook, X – l’ex Twitter –, YouTube e TikTok, progettate per massimizzare il tempo di permanenza e l’engagement, premiano contenuti emotivamente carichi, divisivi e semplicistici.
Questo non è un effetto collaterale, ma una caratteristica strutturale dell’economia dell’attenzione descritta nel 2016 da Tim Wu, nel suo libro The Attention Merchants, che privilegia la viralità rispetto alla complessità.

Foto: Unsplash.
Forte ma diversa
Secondo lo studio Social Media and Political Polarization di Ro’ee Levy, il ruolo dei social nella polarizzazione politica è significativo ma non uniforme.
Se da un lato le piattaforme non creano ex novo divisioni, dall’altro amplificano le differenze esistenti e le rendono più radicali, creando “camere dell’eco” che rafforzano le opinioni degli utenti e riducono l’esposizione a prospettive alternative, come sottolinea Cass Sunstein.
Il fenomeno, scrive il professore della Northwestern University, William Brady, si collega all’uso degli algoritmi di raccomandazione, che premiano contenuti che suscitano indignazione – un potente motore di engagement.
Questo meccanismo non solo polarizza, ma incentiva forme di estremismo politico, con conseguenze tangibili: secondo un’analisi realizzata nel 2023 dal Center for Countering Digital Hate, la viralità di contenuti estremisti è spesso guidata da algoritmi, generando profitti pubblicitari per le piattaforme anche su contenuti borderline.

Foto: Unsplash.
Ad esempio, un post
Un piccolo caso relativo a un post su X condiviso dal sottoscritto esemplifica bene le dinamiche che possono svilupparsi.
Il contenuto era incentrato sulla tesi che le eredità siano un fattore di ingiustizia sociale, poiché consentono ad alcuni di iniziare le proprie carriere con un vantaggio – un tema che avrebbe potuto far nascere delle controversie.
Complessivamente il post è stato visualizzato 17mila volte e ha raccolto 76 like, 20 retweet e 84 risposte. Chi scrive ha, a sua volta, risposto dieci volte a dei commenti.
Tuttavia, l’aspetto più interessante da esaminare è stato l’andamento del dibattito.
Nelle risposte di coloro che si dicevano contrari a quanto scritto, prevaleva l’argomentazione secondo cui redditi che concorrono a formare l’asse ereditario sono già stati tassati e, se si introducesse una tassazione sull’eredità, sarebbero tassati due volte.
Le riposte delle persone favorevoli, invece, erano meno visibili, poiché l’approvazione transita normalmente attraverso i like.
Il post stava veleggiando attorno alle diecimila visualizzazioni nelle prime ore dopo la pubblicazione, quando la mattina successiva, il profilo di un giornalista sotto pseudonimo ha pubblicato due post.
Nel primo, ragionava sui pericolosi tentativi di espropriare la proprietà privata e sul suo carattere intoccabile. Nel secondo, di due righe, proclamava che il leninismo è morto e che la proprietà privata è sacra.
Molti dei suoi follower sono intervenuti a sostegno della sua argomentazione e i messaggi si sono fatti via via più estremi, minacciosi e violenti, attribuendo all’interlocutore di sostenere cose che, in realtà, non ha scritto.
Nella fase finale del thread, sono comparsi i commenti di personaggi più improbabili, che nella loro timeline hanno nostalgie della Santa Inquisizione o del nazismo.
Dunque, nella seconda ondata di commenti il punto di partenza non riguardava più il messaggio originario, ma era la deriva scollegata e dettata dal giudizio forzato di un altro.
A dimostrazione di come i messaggi si fanno più estremi e generalizzati man mano che ci si allontana dalla discussione originaria, si parla a un’ipotetica squadra avversaria e la denigrazione diventa un elemento crescente dei post.

Foto: Unsplash.
Quanto costa la polarizzazione
Il costo economico della polarizzazione e dell’estremismo sui social non è trascurabile.
In un’analisi su The Economic Costs of Polarization, si evidenzia come un ecosistema informativo polarizzato generi inefficienze istituzionali, instabilità politica e sfiducia generalizzata nelle istituzioni, danneggiando l’attrattività degli investimenti e aumentando il costo del capitale per le imprese in contesti percepiti come instabili.
Il paradosso è che, mentre le piattaforme digitali hanno democratizzato l’accesso alla pubblicazione e all’informazione, il loro modello di business incentiva un comportamento collettivo che riduce la qualità del discorso pubblico, semplificando ed estremizzando le posizioni e favorisce l’ascesa di leader politici capaci di sfruttare la comunicazione semplificata e polarizzante.
Il problema non riguarda solo la sfera civica, ma impatta direttamente sull’economia.
La radicalizzazione del dibattito porta a conflitti sociali, instabilità normativa e incertezza politica, fattori che generano un “costo della polarizzazione” in termini di crescita potenziale, come dimostrano le evidenze di Alberto Alesina e Guido Tabellini.
Il mercato dell’attenzione, se lasciato privo di correttivi, genera esternalità negative che nessuna economia avanzata può più permettersi di ignorare.







