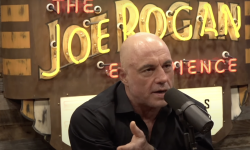Foto copertina: Unsplash.
La diffusione e il sopravvento dei nuovi media e la conseguente perdita di importanza delle testate tradizionali hanno fatto sorgere un dubbio legittimo: se abbia ancora senso parlare di agenda setting da parte di tg e giornali.
I media cosiddetti mainstream “non sono più la fonte principale di informazione. Non sono così importanti”, aveva detto a Mediatrends Charlie Beckett, professore della London School of Economics, dove ha fondato e dirige il centro di ricerca per il giornalismo Polis, ed ex giornalista di Bbc e Channel 4.
Sebbene questa tesi sembri essere confermata dai numeri crescenti di podcast e informazione social a discapito della tv via cavo e dei giornali cartacei, i tradizionali canali di informazione contano ancora nel plasmare il sentimento collettivo dell’opinione pubblica.
O, per essere più specifici, hanno contribuito per anni e in maniera pesante a portare il dibattito pubblico al livello di polarizzazione che si ha oggi nei Paesi occidentali.

Foto: Unsplash.
Dalla tv ai social
Più che il classico lavoro di selezione dei singoli temi da offrire in pagina o in scaletta, come ai tempi d’oro dei quotidiani e dei telegiornali, il ruolo dirimente – e dannoso – delle televisioni è stato un altro: prediligere determinate macro aree di informazione rispetto ad altre per massimizzare gli ascolti.
In particolare, sostiene il Financial Times menzionando i risultati di uno studio firmato da due economisti di Mit e Harvard, dal 2000 circa in poi le tv via cavo si sono rese conto che notizie relative alla criminalità, all’immigrazione, al razzismo e alle questioni di genere generavano più coinvolgimento e aumentavano l’audience perché divisive.
Per questo, negli ultimi 25 anni, i programmi televisivi di informazione hanno dedicato molto più spazio a questi argomenti, lasciandone sempre meno alle tematiche socio-economiche.
A completare il lavoro di polarizzazione ci hanno pensato i social media, sottolinea una seconda ricerca menzionata dal Financial Times e condotta da ricercatori della Northwestern University e dell’Università di Chicago.
Una prima ondata, iniziata attorno al 2010 e durata per circa dieci anni, ha inaugurato la stagione delle filter bubble alimentate dall’algoritmo dei mi piace dei social, premiando post che confermavano le opinioni politiche del proprio gruppo di appartenenza, screditando le visioni differenti e inserendo una quantità crescente di contenuti politici nel feed.
Anche il famigerato algoritmo di TikTok, passato dal meccanismo dei like a metriche più sensibili e accurate, ha dato un’ulteriore spinta alla polarizzazione politica: i contenuti negativi che criticavano e attaccavano gruppi avversari erano in maggioranza rispetto a quelli positivi, che elogiavano i componenti della propria area di appartenenza.

Foto: Flickr.
Vecchia storia
Non è di certo la prima volta che gli scienziati sociali riflettono sul contributo e sugli effetti dei media e delle piattaforme nel plasmare l’opinione pubblica, soprattutto nelle democrazie liberali occidentali.
Tra i diversi esempi, un noto studio del 2007 firmato dall’economista italiano Stefano DellaVigna e dal professore americano Ethan Kaplan analizzava i dati elettorali di oltre novemila città statunitensi in cui Fox News aveva iniziato a trasmettere le proprie trasmissioni, a partire da ottobre del 1996.
La ricerca mostrava come in queste città il partito repubblicano avesse aumentato i propri voti di un range compreso fra 0,4 e 0,7 punti percentuali tra le elezioni del 1996 e quelle del 2000.
Tuttavia, se sulla responsabilità dei mezzi di informazione e dei social restano pochi dubbi, è più difficile provare ad avanzare delle soluzioni efficaci.
Un articolo pubblicato nel 2021 dall’Economist riprendeva i risultati del libro Breaking Social Media Prism, scritto dal docente di sociologia della Duke University Chris Bail.
Basato su un’analisi condotta su un campione di circa 1.200 utenti statunitensi di Twitter, ai quali Bail aveva chiesto di seguire per un mese dei bot che pubblicavano contenuti politici al loro credo di appartenenza, lo studio aveva portato a un risultato interessante: i partecipanti che si dichiaravano di destra si erano spostati ancora più a destra e quelli di sinistra più a sinistra.
Per questo, sosteneva il docente, uscire dalla bolla può provocare ancora più danni di quelli che produce rimanendo al suo interno, se prima non si ricostruisce un’abitudine al confronto e alla discussione.