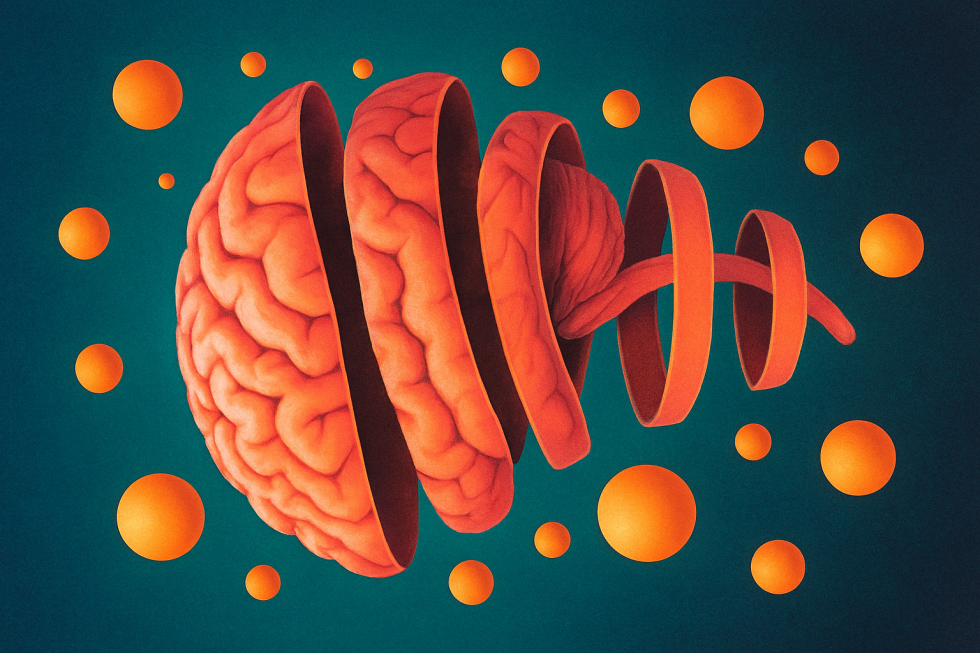
Foto copertina: immagine generata con ChatGpt.
Creare una nuova parola o uno slang virale sta diventando un’attività molto frequente e anche redditizia.
A spiegare perché nascono nuove parole è Etymology Nerd, pseudonimo di Adam Aleksic, linguista americano e content creator da oltre 650mila follower su YouTube.
In un articolo per il Financial Times, Aleksic – che ha scritto Algospeak: How Social Media is Transforming the Future, spiega come un linguaggio di nicchia entri in circuito di engagement, per diventare virale e fare trend.
E come questo influenzi le azioni stesse.
@etymologynerd I talk more about the brainrot aesthetic on my substack! #brainrot #linguistics #language #etymology #woty #words #word #skibidi #aesthetics #art ♬ original sound – etymologynerd
Perché le parole vanno di moda
Dopo gli studi a Harvard, Etymology Nerd ha iniziato a fare video su TikTok per analizzare l’origine delle parole ma anche come il loro utilizzo si modifica, non solo sui social ma nella vita reale.
Le pillole di Etymology Nerd non sono banali: cita dati, paper, approfondisce, per quanto consentito nel format che ha scelto. Spazia dall’arte contemporanea alla filosofia e le sue visualizzazioni arrivano a essere milioni.
E se il linguaggio serve a comunicare e si vive l’epoca per eccellenza della comunicazione, si capisce perché solo nel 2024, Treccani ha inserito decine di neologismi, alcuni dei quali tipicamente italiani.
Pandoro-gate o barberismo sono degli esempi, accanto ai più internazionali trend come quello di stile “demure”, o ad altri meno noti o praticati come sdigiunino.
La parola creator è entrata definitivamente a far parte del vocabolario italiano, legittimando e riconoscendo ulteriormente la professione.
Se la società cambia in modo sostanziale, accade che non si trovino i termini per definire i nuovi fenomeni.
Si pensi al caso del quiet quitting, a cavallo della pandemia: un termine finito sulle scrivanie e nella formazione delle risorse umane delle aziende di tutto il mondo.
Ma quello che emerge dagli ultimi slang è diverso e ha meno a che fare con le azioni reali e più con le interazioni social.
Anche la creazione di nuove parole, in sostanza, è fagocitata dal funzionamento dei social media.

Un Lego ispirato alla saga di Star Wars. Foto: Unsplash.
Attenzione e acquisto
Tra gli esempi di questa estate ci sono parole come clanker o brainrot.
La prima è nata tra i fan di Star Wars, che hanno cominciato a usarla come declinazione denigratoria verso i robot.
Una parola nata – con tutte le difficoltà nell’attribuzione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale – dentro un gruppo ristretto, e che per Aleksic si spiega addirittura con il concetto di “differente” del filosofo Jacques Derrida.
Ma da quell’universo immaginifico specifico la parola è potentemente esplosa, in modo incontrollato.
È accaduto anche a skibidi o labubu, il cui mix di estetica, comicità e aggressività ha creato fenomeni commerciali enormi, come nel caso del matcha dubai chocolate.
Spesso, nei video, tutte queste parole comparivano insieme, esattamente come si stesse scrivendo una Seo.
L’algoritmo inverte il legame di causa della creazione delle parole: è dalla parola che nasce il fenomeno e non più viceversa.
“Questo accade perché oggi tutte le parole sono metadati – elementi che forniscono informazioni sul contenuto. Gli algoritmi analizzano ogni parola di un video, e tutte concorrono a determinarne la circolazione”, scrive Aleksic.
Parole come clanker sono state spinte dall’algoritmo, fino a perdere la matrice contestuale – e cioè un universo di finzione – e cavalcare un più orizzontale sentimento anti-IA.
Nuove parole di nicchia diventano virali perché vengono servite come pasto non richiesto sui propri feed, spesso potenziate da un carattere sottilmente aggressivo e viscerale di quel contenuto.
Uno schema che potrebbe persino essere architettato ad hoc per spingere dei contenuti e dei prodotti.
E il pubblico sembra essersene accorto.
Anche se commercializzato e spinto anch’esso dall’algoritmo, l’uso del termine brain rot denota una consapevolezza e una stanchezza: come se qualcosa stesse cominciando a rompersi nella promessa di creatività individuale che ci si aspettava dai social.
Scrive Aleksic che “non c’è nulla di linguisticamente dannoso in questo fenomeno. Anche se chiamato brainrot, lo slang non è deleterio per la mente. Piuttosto, il linguaggio è un campanello d’allarme per cambiamenti culturali più ampi”.

“Merda d’artista”, opera del 1961 di Piero Manzoni. Foto: Flickr.
Parlare bene per agire meglio
La qualità percepita di queste proposte, spiega Aleksic, potrebbe anche dipendere dal contesto.
L’autore, riferendosi a skibidi toilet, implicitamente sembra riferirsi a opere come La merda d’artista di Piero Manzoni, aggiungendo che la low art è quella per definizione attribuita ai social, mentre basta una galleria per parlare di arte vera e propria.
Non si tratta però solo di questo, ma dell’esperienza cognitiva che si fa nel fruire di un contenuto in un contesto fisico di un certo tipo.
Ed è un fatto che non si può ignorare, anche perché la tendenza del fenomeno virale per un certo periodo di tempo sta invadendo tutti i campi della creatività e anche della politica, sempre meno fisica e più digitale.
Mentre il carattere smaterializzato dei contenuti influisce sulla loro permanenza nel tempo, non altrettanto immateriali sono i loro impatti.
Nel 2016, il Guardian si chiedeva: se la lingua inglese ha già milioni di parole a disposizione, perché ogni anno se ne aggiungono almeno mille?
Esistono sinonimi nella propria lingua di cui neanche si è a conoscenza.
Il New York Times, che ha un approccio creativo – quasi da trend-setter – ai neologismi, ha persino dedicato una pagina intera alle parole.
Si chiama Word of the Day, e ogni giorno pubblica parole desuete, ma anche molte appena create o rimesse in circolo da fenomeni culturali, sfidando i lettori a farne uso in una frase.
Il potenziale connotativo delle parole è enorme, anche perché spesso riguardano un intero patrimonio culturale, mentre molti dei nuovi slang hanno matrice esclusivamente anglofona.
Per Aleksic, la lezione dello slang è chiara: “la nostra cultura oggi viene plasmata da sorveglianza, dati e priorità di business delle piattaforme. Più ne siamo consapevoli, più potremo recuperare quella sensazione di autenticità e significato che si è persa nel web”.
Questa pratica di creare neologismi globali ha dei rischi.
Lo slang perde la sua funzione di riconoscimento identitario tra membri di una comunità, diluendosi in un uso massificato.
Le parole stesse, spesso passeggere, perdono un potere denotativo, ma ne acquisiscono uno di condizionamento delle azioni.
Se “tapis roulant dell’engagement”, come lo definisce Aleksic, si sta spingendo oltre l’adagio di John Austin, autore di How To Do Things with Words.
Da “come si fanno le cose con le parole”, a “quello che le parole ti fanno fare”.









